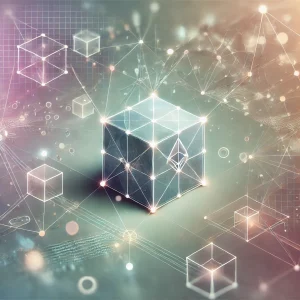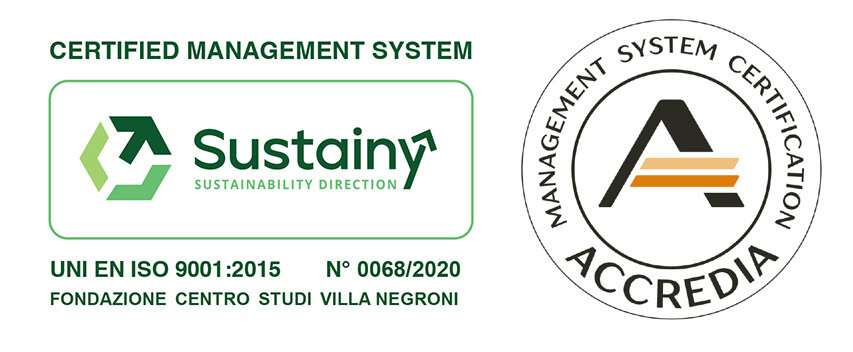Nel 2021 FINMA ha lanciato un progetto pluriennale con lo scopo di integrare i fattori climatici nel piano di vigilanza ma, già oggi, gli istituti finanziari devono considerare tali rischi e, se ritenuti materiali, anche pubblicarli.
I rischi climatici possono essere suddivisi in due categorie: rischi fisici e di transizione. I primi derivano da catastrofi naturali causate da eventi atmosferici estremi o generati dal cambiamento climatico. I rischi di transizione, invece, sono la conseguenza di cambiamenti nella politica climatica o regolamentazioni che possono provocare maggiori costi ai settori assoggettati.
Gli effetti dei rischi climatici, siano essi fisici o di transizione, si riflettono sugli istituti finanziari e i portafogli dei clienti o gestiti per conto proprio. Si pensi ad esempio all’impatto che potrebbe avere una regolamentazione più stringente nei settori ad alta intensità di emissioni di carbonio come l‘energia, l‘industria o i trasporti. L’aumento dei requisiti regolamentari potrebbe generare maggiori costi per le aziende assoggettate, con una conseguente minore redditività e, di riflesso, un adeguamento al ribasso del corso azionario o un maggior costo di rifinanziamento nel mercato dei capitali.
I mercati potrebbero, inoltre, scontare i rischi climatici nei prezzi dei vari strumenti finanziari con oscillazioni anche importanti. Questo avrebbe un impatto diretto sul valore dei titoli dei propri investimenti, su quelli dei clienti e sui collaterali dati in pegno per crediti concessi, con conseguenti impatti sulla redditività di banche, assicurazioni e gestori patrimoniali.
Nel corso degli ultimi anni, nel mondo dell’asset management, si è assistito a un crescente interesse verso strumenti sostenibili. Numerosi gestori di fondi hanno iniziato a implementare fattori ESG (Environmental, Social and Governance) nelle loro strategie di investimento, avviando un dialogo diretto con le aziende, affinché quest’ultime dimostrassero di avere un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.
Tale tendenza è stata, inoltre, amplificata dall’arrivo della pandemia Covid-19, in quanto ha richiamato all’attenzione istituzioni governative, aziende e fondi di investimento per aumentare il proprio contributo ai fini di una ripresa più “green”, ovvero più focalizzata sulle questioni ambientali e sociali. Basti pensare che un terzo delle risorse del piano Next Generation EU, introdotte per la ripresa economica, verranno destinate per finanziare una serie di proposte tese a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Recentemente si è tenuta a Glasgow la ventiseiesima conferenza delle Nazioni Unite, nota come COP26, che ha riunito i principali leader di tutti i Paesi del mondo, con lo scopo di concordare un’azione comune per combattere la crisi climatica. L’aspetto certamente più interessante che emerge dagli accordi raggiunti è che, nei prossimi anni, verranno disposti circa 130mila miliardi di dollari da parte di una coalizione composta da più di 400 banche, assicuratori e gestori patrimoniali con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica nell’arco dei prossimi tre decenni. In altre parole, anche i mondi della finanza e del risparmio gestito sembrano essere fortemente interessati a cavalcare l’onda “green”, promuovendo ai propri clienti prodotti conformi ai fattori ESG e SRI (Sustainable and Responsible Investing). Come emerge, infatti, da uno studio condotto da Morningstar, la richiesta di fondi ed ETF (acronimo di Exchange Traded Fund) da parte degli investitori è decuplicata negli ultimi cinque anni. Nel 2020 il patrimonio netto investito in fondi sostenibili è cresciuto più del 50% rispetto al 2019, attestandosi intorno ai 1’100 miliardi di euro, mentre circa 9’000 miliardi di euro sono allocati in fondi “convenzionali”. Sulla base di quanto detto, ci troviamo in un periodo in cui “essere sostenibili” viene percepito come un valore aggiunto per i vari stakeholders, soprattutto se si volge lo sguardo ai rendimenti generati. In aggiunta a ciò, le decisioni prese da grandi istituzioni finanziarie, ad esempio il fondo pensione della Norvegia o BlackRock, hanno creato un momentum favorevole per gli investimenti sostenibili.
Tuttavia, se da una parte il ventaglio di offerta sostenibile dei gestori di fondi si è allargato sempre di più negli ultimi anni per rispondere alle esigenze del mercato, dall’altra sussiste il rischio che tali operatori possano sopravvalutare l’effettiva utilità ambientale e sociale dei loro prodotti. In altre parole, spinti da motivi reputazionali e questioni commerciali, gli investitori sono sempre più esposti a un implementato rischio di “greenwashing”, ovvero il fenomeno in cui gli operatori finanziari dichiarano di adottare un approccio sostenibile, quando in realtà le politiche decisionali in materia ESG mancano di qualità, consistenza e trasparenza. Come emerge da un articolo del World Economic Forum, circa l’80% degli ETF classificati come “ESG compliant” in realtà presenta un’esposizione verso aziende operanti nel settore dei combustibili fossili. Sulla base di quanto si evince da un’intervista condotta da Capital Group all’interno dell’industria dell’asset management globale, circa il 63% degli investitori nel Nord America afferma che il “greenwashing” è diventato prevalente nel settore, mentre in Europa e nella regione Asia-Pacifico le percentuali si attestano, rispettivamente, al 56% e al 55%.
Recentemente, il think tank Influence Map ha condotto uno studio volto a verificare se il campione selezionato, composto da 723 fondi azionari etichettati ESG con un patrimonio totale di oltre 300 miliardi di dollari, sia allineato con gli Accordi di Parigi e se abbia investimenti in società appartenenti a settori controversi. Ciò che emerge dalle loro analisi è che circa il 70% del campione ha ottenuto un punteggio negativo, ovvero le aziende presenti all’interno dei loro portafogli sono disallineate rispetto agli obiettivi climatici globali stabiliti a Parigi, evidenziando scarsa trasparenza e qualità in tema ESG. Inoltre, alcune di queste imprese sono attive nella produzione di combustibili fossili, per un controvalore complessivo di 150 milioni di dollari circa. Questi risultati negativi sono in larga parte legati al fatto che i gestori di fondi non sono obbligati a comunicare il 100% dei componenti posseduti. Inoltre, le strategie adottate nei singoli ETF/fondi possono differire; un esempio è dato dal fatto che in alcuni casi vengono esclusi specifici settori (come il tabacco), mentre in altri ci si focalizza nel rating ESG, generando confusione tra gli investitori retail.
Ad oggi, secondo quanto sottolineato da Capital Group, i policymakers hanno un ruolo fondamentale per risolvere il problema del Greenwashing. Circa il 47% degli intervistati crede che l’introduzione di standard minimi, per qualificare come sostenibili prodotti e servizi di investimento, possa aiutare a tutelare gli investitori. Invece, il 55% dei professionisti è d’accordo nell’affermare che è possibile superare tale fenomeno aumentando la qualità e la trasparenza della reportistica dei fondi, dettagliando come gli investimenti sostenibili verranno gestiti e monitorati.
Sulla base di quanto emerso da alcuni articoli del Journal of Portfolio Management e dal Journal of Sustainable Finance & Investment, le aziende con rating ESG elevato registrano una performance aggiustata per il rischio decisamente superiore rispetto alle imprese con punteggi inferiori. Dunque, oggigiorno, non ci sono dubbi sul fatto che gli strumenti sostenibili possano contribuire positivamente sui rendimenti del portafoglio, oltre al fatto che tali investimenti potranno beneficiare nel breve e medio termine della risonanza mediatica attribuita da Governi, Istituzioni e aziende.
Occasione di approfondimento delle tematiche sopra illustrate è il corso Gestione dei rischi climatici e ambientali in ambito bancario e nella gestione patrimoniale che avrà luogo a Villa Negroni il 9 febbraio 2022, dalle 13.30 alle 17.00.